Autore: Dott. Antonello Schiaccitano
vedi Sito Internet dell’Autore http://www.sciacchitano.it/Esempio_di_cura_non_medica.html/
Ringrazio Luciana Pisciottano per avermi invitato a parlare alla Cascina Cuccagna.
A dir la verità non ho capito bene a che titolo mi ha invitato. Forse avere sette nipoti costituisce un titolo per parlare della nonnità. Allora mi presento come nonno Biancaneve. Ma vi rassicuro: non parlerò del mio caso personale. Purtroppo non vi parlerò neppure della trasformazione della città da tradizionale a metropolitana, come prevede il tema di oggi, perché non sono un sociologo e non ne ho la competenza.
Allora, come posso parlare del fenomeno “nonno”? Intendo parlare della funzione del nonno come fattore di civiltà. In particolare, parlerò del nonno come fattore di conservazione della civiltà. In generale il nonno non è un innovatore; ma la sua funzione non è meno importante; se non ci fosse la sua funzione di conservazione e di trasmissione della civiltà alle nuove generazioni, la civiltà si sgretolerebbe.
Allora, come posso parlare di questa funzione “nonnesca”? Ebbene, essendo io di formazione scientifica, ho pensato di raccontarvi due storielle pseudoscientifiche, ma in fondo in fondo non troppo pseudo: una storiella biologica o darwiniana e una storiella psicanalitica o freudiana; una più legata all’aspetto collettivo della civiltà, l’altra all’aspetto individuale. Le due storielle sono complementari; riguardano le due facce della stessa medaglia: la civiltà umana; la prima è più edificante e ottimistica, dà qualche speranza; la seconda è un po’ più pessimistica e, se proprio non inibisce le speranze, comunque suggerisce di assumere un atteggiamento critico riguardo alla nostra civiltà.
La prima storiella comincia sei milioni di anni fa. Non la faccio lunga, come potrebbe sembrare da questa cifra. Sicuramente voi tutti, me compreso, non riuscite a farvi un’idea molto precisa di cosa significano sei milioni di anni. Sono pochi, sono molti? Sicuramente sono pochi rispetto all’età dell’universo, che è stimata in 13 miliardi e settecento milioni di anni. Sono relativamente pochi anche sia rispetto alla vita della terra, che data da quattro miliardi e mezzo, sia rispetto alla vita sulla terra, che risale a tre miliardi di anni fa, sotto forma di colonie dei primi batteri. Ma sicuramente sono molti rispetto alla storia dell’uomo. A scuola ci hanno insegnato che la storia comincia con la scrittura, ma la scrittura non risale a oltre cinquemila anni fa, un nonnulla rispetto ai sei milioni. Come vedete, l’origine dell’umanità si perde nelle nebbie del tempo geologico.
Sei milioni di anni fa si verificò un evento cruciale o, come si suol dire, epocale: all’interno dell’ordine dei primati gli ominidi si separarono dagli scimpanzé, i grandi e i piccoli, detti anche bonobo. Purtroppo non abbiamo registrazioni fossili sicure di questa separazione. La data è stimata attraverso gli orologi molecolari, regolati sulla frequenza di mutazione del dna: essendo questa relativamente costante, più mutazioni si registrano, più indietro nel tempo è avvenuta la separazione. In base a questi dati cronobiologici, sappiamo che la separazione genetica tra l’uomo e gli scimpanzé esiste, si può misurare, ma è piccola. Non è superiore all’1,5 per cento e dai calcoli statistici risale appunto a sei milioni di anni fa. In altri termini, da un bel po’ di tempo possediamo ben il 98,5 per cento di geni in comune con gli scimmioni.
Allora, qual è la differenza? Non mi risulta che gli scimpanzé abbiano inventato il teorema di Pitagora o costruito la bomba atomica. Non mi risulta neppure che abbiano realizzato dei genocidi. Pare che il genocidio sia una caratteristica specifica dell’uomo, forse più peculiare del linguaggio. Esempi? il genocidio degli armeni da parte dei turchi, dei tasmani da parte degli australiani, degli ebrei da parte degli ariani, dei tutsi da parte degli utu. Gli scimpanzé sono aggressivi tra loro; i loro branchi si combattono tra loro, attaccano individui isolati del branco confinante e li uccidono, ma non hanno mai né progettato né eseguito genocidi di massa di altri scimpanzé. Il genocidio non si spiega solo in base all’aggressività primordiale comune a tutti gli esseri viventi nei confronti degli altri viventi. Ci vuole un’intelligenza superiore per realizzare un genocidio. Come quella dell’uomo?
La differenza genetica tra uomo e scimpanzé è quantitativamente piccola ma qualitativamente enorme. Ma questo è il punto: è solo una differenza genetica?
La differenza genetica pur piccola è decisiva. Sappiamo che tra i geni specifici dell’uomo e assenti nello scimpanzé compare quello che regola la pieghettatura del mantello cerebrale, che gli scimpanzé non hanno; la corteccia cerebrale degli scimpanzé ha meno circonvoluzioni di quella dell’uomo; questo è un fattore che condiziona decisamente l’intelligenza cognitiva delle due famiglie. Nello scimpanzé, inoltre, manca anche il gene che regola la formazione del polso. Senza la mano, dotata di pollice opponente, l’uomo non sarebbe uomo; non sarebbe Homo habilis, capace di intagliare la pietra per creare asce, frecce e cacciare gli animali. La mia congettura, che tuttavia non so dimostrare, è che senza la mano, cioè senza le abilità tecniche, l’uomo non saprebbe neanche parlare.
Ma la differenza genetica non spiega tutto. C’è una differenza culturale, originata sì dalla genetica, ma sviluppatasi indipendentemente da essa. Cerco di raccontare in poche parole come sono andate le cose.
Dei suddetti sei milioni di anni, quasi due terzi filarono via lisci, tranquillamente amministrati dal tran tran della selezione darwiniana, che ha portato a proliferare maggiormente le specie meglio adattate all’ambiente. Per milioni di anni le specie di australopitecine si succedettero le une alle altre senza grossi traumi: ne nascevano nuove specie, ne morivano di vecchie in media ogni tre milioni di anni. Ma nell’ultimo terzo del periodo successe un evento sconvolgente: due milioni e quattrocentomila anni fa, Lucy, un’australopitecina femmina, dalle parti dell’odierna Afar in Etiopia, ebbe un’idea tanto bizzarra quanto sconvolgente: scese dall’albero dove viveva, si alimentava, copulava e generava prole, al riparo dai predatori, e cominciò a camminare a due zampe per la savana dell’Africa orientale. Quando si dice le donne… ne pensano una più del diavolo.
Fu una rivoluzione, ben superiore a tutte le rivoluzioni che la nostra storia conobbe in seguito: dalla francese all’industriale. La posizione eretta produsse innanzitutto una catastrofe anatomica individuale. Per muoversi su due zampe invece che su quattro Lucy dovette modificarsi la struttura del bacino; la colonna vertebrale dovette cambiare assetto e diventare veramente la colonna portante di più della metà del corpo; cambiò anche l’equilibrio a sostegno del cranio, che non era più pendulo in avanti, ma stava in bilico sulla colonna vertebrale. Questi cambiamenti ebbero successo: furono premiati dalla selezione naturale. Non sto a dire tutti i vantaggi: espansione della scatola cranica, che poteva ospitare un cervello più grande, formazione di un ampio cavo orofaringeo adatto alla parola, liberazione delle mani per operazioni tecniche complesse: dall’elaborazione al trasporto di oggetti ecc.
Per avvicinarmi al tema di partenza segnalo uno svantaggio decisivo della stazione eretta: la restrizione del canale del parto nella madre, dovuto alla rimodulazione del bacino, e parallelamente l’aumento di volume della scatola cranica del figlio. Di conseguenza i figli dei primi ominidi dovevano o non nascere, e quindi gli ominidi si sarebbero estinti, o nascere più piccoli e quindi prematuri; il termine tecnico è neotenici.
La scelta fu obbligata, come si può capire. Ma le conseguenze dell’opzione neotenica non si fecero sentire solo sul piano individuale del singolo soggetto neotenico, ma si estesero subito al piano collettivo, dove il singolo viveva. L’individuo neotenico aveva bisogno di una struttura sociale stabile dove crescere e svilupparsi. Occorreva una famiglia relativamente duratura che lo accudisse e lo allevasse fino al raggiungimento della maturità e dell’autonomia. L’amore di coppia fu favorito dalla selezione culturale perché promuove la crescita dei figli, che è impresa non da poco. Oggi l’uomo per arrivare alla maturità ci mette convenzionalmente diciotto anni, quando il ragazzo fa l’esame di maturità.
Nacque così la prima forma di società umana. Il primo passo fu la scelta del nido in anfratti naturali, dove allevare la prole; in seguito divenne costruzione architettonica di capanne e di tuguri. Il secondo passo fu la necessità che un genitore rimanesse “a casa”, cioè nel nido, mentre l’altro usciva a foraggiare. In genere la madre restava a casa ad allattare mentre il padre andava a cacciare e raccogliere. La società dei cacciatori-raccoglitori precedette la società degli agricoltori. Quando il gruppo si accresceva e occorreva più cibo, anche la donna doveva uscire di casa anche lei per cacciare e raccogliere nella boscaglia. E i figli? I figli furono affidati ai primi babysitter della storia – io faccio parte di questa gloriosa tradizione – i nonni. I nonni, che da giovani raccoglievano e cacciavano anche loro, da vecchi si specializzarono in una nuova “professione”: la cura dei bambini. La cura divenne una funzione sociale importantissima e fu fisiologica prima che terapia di patologie mediche.
Spero di essere riuscito a questo punto a farvi intravedere la funzione culturale del nonno. Stiamo per andare al di là della genetica. Il nonno fa da vicepadre e da vicemadre per far crescere la progenie. In termini strettamente biologici il nonno “cura” il patrimonio genetico che è uscito da lui e si è diversificato e arricchito con apporti esterni. Ma c’è di più che la biologia. Durante la “cura” il nonno opera una trasmissione di cultura. Il nonno trasferisce ai nipoti un patrimonio culturale fatto innanzitutto di linguaggio; trasferisce il tesoro delle favole e dei miti che fondano la collettività; a cominciare dai giochi e per gioco trasferisce ai nipoti le competenze sociali che saranno necessarie ai futuri adulti per vivere e operare nella società. Insomma, il nonno è il primo maestro di vita. In questo senso, come dicevo prima, il nonno opera come fattore di conservazione sociale. Il nonno è strutturalmente conservatore, direi, senza offesa, “di destra”. Conserva e trasmette la civiltà che ha ricevuto dai padri alla generazione che viene dopo quella dei suoi figli. Giustamente si parla di seconda generazione, perché è una generazione di secondo livello, non biologico ma culturale.
Questa è, per sommi capi e molto semplificata, la storiella darwiniana che volevo raccontarvi. I nonni sono stati selezionati positivamente dalla selezione naturale, che ormai ai nostri giorni è diventata culturale, e quindi agisce con ritmi più rapidi della selezione biologica, perché consolidano la società in cui vive l’essere umano. La “curano”. I primi nonni, lo dico per concludere la storiella darwiniana, erano giovanissimi e fisicamente ancora validi. I Neandertal diventavano nonni a trenta-quarant’anni; morivano prima dei cinquanta; di bisnonni non se ne parlava proprio. Ciò non impediva la trasmissione nonno-nipote della cultura nel pur breve lasso di tempo della loro vita. Probabilmente, senza la funzione svolta dai nostri nonni non saremmo qui a parlarne. Siamo in debito culturale con la generazione che ha preceduto i nostri padri biologici. È un debito che a nostra volta pagheremo assistendo – la parola pregnante è “curando” – i figli dei nostri figli.
Tutto bene, allora? Tutto rose e fiori? Sì e no. Dal punto di vista biologico non ci sono dubbi: i nonni svolgono una funzione positiva per la civiltà. Lo psicanalista è d’accordo con questa visione ma con un granellino di sale, un po’ amarognolo, per la verità.
[Aggiungo tra parentesi – trascrivendo il mio intervento – che sto parlando a buon diritto del nonno, non solo perché di fatto sono il nonno biologico di sette nipoti, ma soprattutto perché sono un nonno culturale. Lo psicanalista è culturalmente e in linea di principio un “nonno”, perché, da vero nonno, cura la civiltà. Offre alla civiltà una cura non medica, che a volte, anzi troppo spesso, assume la falsa sembianza della cura medica – la malfamata psicoterapia –, perché cura quelle false malattie che sono le cosiddette malattie mentali, le quali prendono sì consistenza nell’individuo – come nevrosi, psicosi e perversioni – ma sono originariamente squilibri e alterazioni della vita sociale nel suo complesso.]
Lo psicanalista lavora in un osservatorio che mette a fuoco il lato malfunzionante della vicenda umana. Dovrei dire il lato “patologico”, ma non uso questo termine perché introduce una connotazione medica che voglio lasciare fuori dal mio discorso. Potremmo parlare a lungo, ancora in termini darwiniani, degli aspetti malfunzionanti della civiltà, perché anche loro sono stati selezionati da quel mix di selezione genetica e culturale, precisamente dalla selezione individuale e dalla selezione di gruppo, che sembra una caratteristica propriamente umana, la prima a favore dell’individuo, la seconda spesso a suo discapito. Lo scimpanzè – dicevo prima – non ha inventato né il teorema di Pitagora né la bomba atomica. Sia l’uno sia l’altra sono portati della cultura. La cultura porta il bene – il teorema di Pitagora – e il male – la bomba atomica – in un modo che è problematico a volte sceverare. Lungo la discendenza degli scimpanzé non è passata quella corrente di sapere culturale, interamente artificiale, cioè prodotto da se stesso, che ha trascinato con sé conseguenze in parte buone e in parte cattive per la stessa sopravvivenza dell’uomo, alcune favorevoli alla persona, altre sfavorevoli. Negli ultimi 500 milioni di anni della storia della vita ci sono state cinque grandi estinzioni di massa per cause per lo più ignote. È quasi certo che la sesta avverrà per mano dell’uomo che agisce contro se stesso e contro il pianeta (attacco alla biodiversità, effetto serra, sfruttamento indiscriminato delle risorse ambientali ecc.). E se l’uomo scompare dalla faccia della terra è certo che non vi farà ritorno.
Ho detto che non avrei parlato del mio caso personale. Non parlerò neppure di miei casi clinici, come è brutta abitudine fra gli psicanalisti di professione quando si incontrano e spettegolano sul proprio mestiere. Nella seconda parte del mio intervento leggerò una paginetta di un famoso psicanalista: Sandor Ferenczi, l’enfant terrible della psicanalisi freudiana, che osava contestare il proprio maestro proponendo idee innovative (non da nonno!), ma senza mai diventare eretico. Pur non essendo nonno, aveva la sua da dire sui nonni. Sentite cosa scriveva sul “complesso del nonno” nel 1913, esattamente un secolo fa (come dire oggi su scala biologica).
“Ho notato che il nonno paterno stimola la fantasia del bambino in due modi diversi: da un lato rappresenta il vecchio imponente, che incute rispetto perfino al padre, altrimenti onnipotente, e la cui autorità il bambino vorrebbe far propria per servirsene nella propria ribellione contro il padre; ma, dall’altro, il nonno è anche il povero debole vecchio, sovrastato dalla morte, che da nessun punto di vista (meno che mai da quello sessuale) può misurarsi con il padre, che è ancora nel pieno delle forze, e tale, quindi, da divenire per il bambino oggetto di disprezzo. Molto spesso è proprio la persona del nonno paterno che per la prima volta rende intellegibile al bambino il problema della morte, del definitivo “non esserci più” di un parente; a sua volta, il bambino può trasferire sul nonno paterno le proprie fantasie aggressive di morte rivolte al padre, ma rimosse a causa dell’ambivalenza”.
Voi sapete che la psicanalisi freudiana è fissata al mito del complesso di Edipo, una delle non poche sciocchezze freudiane. Il bambino vuole uccidere il padre e giacere con la madre. Un mito come un altro, secondo me, non vero di principio, anche se spesso vero di fatto.
Continua Ferenczi, citando il suddetto bambino freudiano: “‘Se il padre di mio padre può morire, un giorno morirà anche mio padre (e io entrerò in possesso dei suoi privilegi)’” – cioè entrerò in possesso della madre. “Più o meno questo è il contenuto della fantasia che di solito si cela dietro ricordi e fantasie di copertura che ruotano intorno alla morte del nonno. Inoltre, in seguito alla morte del nonno, la nonna ritorna nubile; ecco, allora, che alcuni bambini, per salvare la vita del padre e al tempo stesso possedere la madre da soli, ricorrono all’espediente di far morire in fantasia il nonno, regalare la nonna al padre e tenersi la madre”. (Risata generale) Avete ragione a ridere. Non c’è buona psicanalisi che non sia spiritosa. Dopo vent’anni di analisi, non ti resta che andare a Lourdes – diceva Woody Allen. Viceversa, un buon motto di spirito veicola sempre qualcosa di psicanalitico.
Di mio aggiungo solo che posso confermare l’analisi di Ferenczi, problematizzandola quel tanto che i pionieri della psicanalisi non potevano prevedere. Dal mio osservatorio registro i danni della presenza dei nonni, in entrambi i sessi, semplicemente perché chi non ha subito danni, non ha nulla di cui lamentarsi e non fa domanda d’analisi. Chi viene a lamentarsi da me è perché ha subito un danno. Il vero e unico danno da nonno è l’esautorazione del padre. Il grand-père, il grande padre, così si dice in francese “nonno”, esautora il piccolo padre. Se il padre viene esautorato, il figlio non riconosce più la legge del desiderio e non gli resta altra scelta che diventare delinquente o nevrotico. Oggi si fa un gran parlare di padre assente e di società senza padre. È tutto vero e tutto falso e, soprattutto, molti di questi discorsi non sono né veri né falsi, ma servono agli psicanalisti solo per scrivere libri e dire che ci sono: si fanno così pubblicità professionale. Il fatto strutturale è che tra le tre generazioni di nonno, padre e figlio c’è un rapporto problematico, per non dire conflittuale, come usano dire gli psicanalisti. Non tutto il buono sta da una parte, non tutto il cattivo sta dall’altra; tra le parti si crea un equilibrio instabile e quando si rompe sono guai; è vero che il figlio vuole far fuori il padre, ma è anche vero che il nonno vuole riappropriarsi del nipote, per confermare la propria autorità sul figlio; per non parlare della figlia che vuole avere un figlio da o per il padre e vede la propria madre o più spesso la suocera sottrarle il figlio appena partorito con la scusa che sa meglio di lei come si fa a curarlo. Dai tempi di Terenzio il rapporto odioamoroso e rivalitario tra nuora e suocera (per il possesso del fallo, direbbe Freud) è un topos anche teatrale.
Concludo. I nonni sono fattori di conservazione di civiltà e al tempo stesso sono fattori di instabilità della civiltà. Che la civiltà si destabilizzi non è tuttavia, a mio parere, del tutto un male. È anche un bene, perché dalla destabilizzazione possono emergere delle novità e quindi un progresso culturale. In ogni caso, sia nel male sia nel bene, sia che conservino la civiltà vecchia, sia che promuovano la civiltà nuova, noi dobbiamo essere grati ai nonni.
Grazie.
*
Posso aggiungere due parole sulla valorizzazione degli anziani.
I nostri padri latini, gli antichi Romani, avevano trovato un bel trucco per valorizzare gli anziani: li raccoglievano nel Senato (Risa). Il senato era anche etimologicamente il luogo dei vecchi che potevano offrire la loro esperienza nella gestione della cosa pubblica. Anticamente esisteva il vecchio del villaggio che funzionava da consulente psicanalista per il giovane che andava da lui a chiedere: “Come facevi tu ai tuoi tempi in questo caso?” Il trucco non funziona più purtroppo, perché la vita cambia così rapidamente che quel che i vecchi da giovani sperimentavano della vita non vale più oggi che sono diventati vecchi. Oggi abbiamo il problema di aggiornare i vecchi, per non renderli obsoleti. Allora i vecchi devono tornare a scuola; l’università della terza età è un trucco che viene proposto al posto del o insieme al Senato, dove siedono senatori a vita.
*
Posso aggiungere altre due parole sulla cura nella e della città in nome della psicanalisi.
Un grande filosofo del secolo scorso, Michel Foucault, scrisse un libro, intitolato La cura di sé. Quel che emerge è che la cura di sé non va da sé. Soprattutto la cura di sé non può essere la cura che il Sé dà a se stesso: la cura di sé o è collettiva o non è cura; la cura implica la dimensione comunitaria, mi hanno insegnato quando ero un ragazzino che andava in chiesa. La cura non viene da sola, viene dall’altro e con l’altro. Questo è il punto in cui ci troviamo oggi: una polverizzazione del legame sociale che rende difficile, se non impossibile, l’interazione tra i singoli, quindi la cura reciproca. L’alternativa alla polverizzazione sembra essere la massificazione e l’omogeneizzazione, che altro non è che il modo di trasformare la polvere in palta omogenea. Con il risultato che sta davanti agli occhi di tutti: nella società liquida – come dicono certi sociologi – anche la democrazia è difficile da realizzare, come si constata in Italia in questi giorni.
Anche la psicanalisi freudiana scotomizza il problema. Durante la mia formazione mi hanno insegnato a lavorare sul singolo, che viene da me, si sdraia sul lettino e mi racconta delle cose. Ma questa è solo metà della storia, perché il singolo non esiste singolarmente. Il singolo esiste in più di un intorno collettivo: la famiglia prima, la famiglia seconda, il luogo di studio, il luogo di lavoro, il luogo del dopolavoro ecc. Se non tengo conto del contesto collettivo, non faccio psicanalisi; non faccio cura; faccio al più della terapia medica, cioè ci metto una pezza e basta.
Il problema è a monte, come si diceva nel ’68. Già all’origine, in famiglia e sul lavoro, il legame sociale è polverizzato. In fabbrica o in ufficio l’organizzazione è rigida con un uno che sta sopra e governa i molti che stanno sotto a ogni livello della gerarchia. È efficiente questa organizzazione? Forse c’è di meglio, tanto è vero che i singoli sono a disagio e chiedono la cura allo psicanalista, che tuttavia misconosce le cause del disagio che pretende curare.
Milano, Cascina Cuccagna, 11 maggio 2013
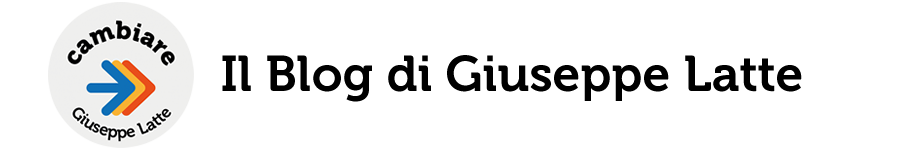
Commenti recenti