Autore: Dott.ssa Emanuela De Bellis
vedi Blog dell’Autore
Le pagine introduttive sono già un pugno nello stomaco (passatemi l’espressione): fin dalla prefazione, il tema centrale viene affrontato in modo diretto, crudo, senza concessioni, né ambiguità. La sculacciata, libro del 2005 del francese Olivier Maurel, presenta con chiarezza la posizione dell’autore sulla violenza educativa.
Il tema viene trattato approfonditamente nei suoi aspetti storici, culturali, legislativi, psicologici. Vengono forniti consigli per chi voglia adottare uno stile educativo senza violenza, vengono riproposte le domande e le repliche più frequenti, viene illustrata una panoramica sulle attuali legislazioni in vigore nei paesi europei ed extra europei.
Ma fin qui niente di nuovo: siamo tutti d’accordo sugli aspetti negativi della violenza su minori. Non abbiamo neanche bisogno di conoscerne nel dettaglio le conseguenze, oserei dire, per decidere che è una pratica non legittima, che lede diritti fondamentali.
Ciò che, a mio parere, merita una riflessione in più è, invece, il contenuto di questa categoria “violenza su minori”.
 Un sondaggio dell’Ipsos, richiesto da Save the Children Italia e riportato nel libro stima che il 67% dei genitori di bambini tra gli 11 e i 16 anni considera la violenza inaccettabile; il 40% ha dato almeno una sculacciata nell’ultimo mese. Questi dati, apparentemente contraddittori, sembrano indicare che la sculacciata non sia considerata una violenza. Io stessa, che predico nell’ambito scolastico e in quello clinico uno stile educativo esente da ogni forma di punizione corporale, da piccola sono stata sculacciata, presa a schiaffi, e non ho mai considerato i miei genitori degli adulti violenti. Anzi, ricordo (con un’alta dose di vergogna) come anch’io sculacciassi i miei nipoti, quando mi veniva chiesto di badare a loro.
Un sondaggio dell’Ipsos, richiesto da Save the Children Italia e riportato nel libro stima che il 67% dei genitori di bambini tra gli 11 e i 16 anni considera la violenza inaccettabile; il 40% ha dato almeno una sculacciata nell’ultimo mese. Questi dati, apparentemente contraddittori, sembrano indicare che la sculacciata non sia considerata una violenza. Io stessa, che predico nell’ambito scolastico e in quello clinico uno stile educativo esente da ogni forma di punizione corporale, da piccola sono stata sculacciata, presa a schiaffi, e non ho mai considerato i miei genitori degli adulti violenti. Anzi, ricordo (con un’alta dose di vergogna) come anch’io sculacciassi i miei nipoti, quando mi veniva chiesto di badare a loro.
Considerare la sculacciata, o le punizioni corporali più usate, un atto violento vero e proprio, spalanca una porta su un’analisi del proprio comportamento con i bambini.
 Si è abituati a pensare alla sculacciata come a un atto educativo normale, di cui è meglio limitarne l’uso, ma “quando ce vò ce vò”; ci spieghiamo che la usiamo per educare, per insegnare, perché dobbiamo impedire che si faccia del male. Eppure, se proviamo (così come fa l’autore del libro) a cambiare il soggetto che subisce l’atto, ci accorgiamo subito della discrepanza. Se immaginiamo infatti che al posto del figlio ci sia la moglie, la fidanzata, o il dipendente, il detenuto, ci accorgiamo che la frase “lo faccio per educarlo” non suona più come una spiegazione ragionevole, ma come l’alibi usato per secoli per legittimare la violenza del più forte sul più debole. La realtà è che, nella maggior parte dei casi, l’atto violento è una reazione alla rabbia, e solo successivamente viene ri-narrato con una giustificazione educativa. E quando la giustificazione non può più essere sostenuta, cambia anche il vissuto emotivo.
Si è abituati a pensare alla sculacciata come a un atto educativo normale, di cui è meglio limitarne l’uso, ma “quando ce vò ce vò”; ci spieghiamo che la usiamo per educare, per insegnare, perché dobbiamo impedire che si faccia del male. Eppure, se proviamo (così come fa l’autore del libro) a cambiare il soggetto che subisce l’atto, ci accorgiamo subito della discrepanza. Se immaginiamo infatti che al posto del figlio ci sia la moglie, la fidanzata, o il dipendente, il detenuto, ci accorgiamo che la frase “lo faccio per educarlo” non suona più come una spiegazione ragionevole, ma come l’alibi usato per secoli per legittimare la violenza del più forte sul più debole. La realtà è che, nella maggior parte dei casi, l’atto violento è una reazione alla rabbia, e solo successivamente viene ri-narrato con una giustificazione educativa. E quando la giustificazione non può più essere sostenuta, cambia anche il vissuto emotivo.
Ho già accennato alla vergogna se penso a comportamenti violenti che ho usato con i miei nipoti; posso dire di non aver mai alzato le mani su nessun bambino da adulta, ma quante volte, all’interno di un gruppo classe particolarmente agitato, magari all’ultima ora di una giornata stressante, o peggio, quando da giovane lavoravo nei centri estivi, ho usato un tono aggressivo per richiamare all’ordine, quante volte ho alzato la voce, oppure ho minacciato di negare l’uscita in giardino, il gioco libero, ecc…
Faccio questa confessione con difficoltà, e il primo istinto è quello di giustificare i comportamenti, o di minimizzarli. Mi rendo conto che alla base del rifiuto di mettere in discussione di alcune pratiche ci sia un senso di vergogna nel dover ammettere di averle usate. E mi chiedo quindi quanti colleghi, e, ancora di più quanti genitori si ritrovino a usare comportamenti senza aver avuto l’occasione, lo spazio, per rifletterci sopra.

Quante pratiche simili vengono attuate ogni giorno senza la minima preoccupazione per i diritti di un bambino? Quanto può essere percepito terrificante un nel mezzo di alcuni comportamenti? Come mai è così difficile mettere in discussione tali comportamenti? E quali sono le pratiche che possono aiutare per modificare un atteggiamento così diffuso?
Su quest’ultimo punto, purtroppo, il libro è un po’ carente: fornisce qualche consiglio basato sul buon senso, ma nessun percorso alternativo.
Forse il primo passo verso una modifica sociale di questa portata sta proprio nel costruire degli spazi all’interno dei quali si possa parlare del problema, senza sentirsi colpevolizzati. Dove si possa parlare dell’istinto aggressivo anche quando non è manifesto, per ricevere un sostegno al fine di evitarne l’attuazione, o dove si possa condividere le difficoltà di costruire pratiche che i nostri genitori non ci hanno insegnato, e che la società ancora non rimette in discussione fino in fondo.
E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra opinione sulle punizioni corporali? Quali credete possano essere delle buone pratiche alternative? Cosa può fare lo Stato per sensibilizzare al problema? Quali sono i possibili interventi sulla società?
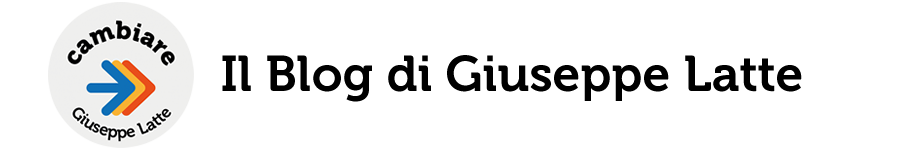
Commenti recenti