Autore: Dott.ssa Morena Romano
Che cos’è la Solitudine? E’ uno stato d’animo o uno stato e basta? Un modo di vivere o un condizionamento?
A molti non piace stare soli, altri lo scelgono, altri lo subiscono, altri fanno di tutto e accettano di tutto pur di evitarlo.
Ma cosa significa essere soli quando soprattutto ci si sente soli in mezzo agli altri?
Il termine solo deriva dal latino solus che indica separazione e quindi implica una condizione che riguarda tutti, ogni essere umano, perché implica la percezione e l’accettazione dell’alterità intesa come Io e Tu.
Da ciò ne deriva che la paura della solitudine è la paura di essere soli con se stessi non più dissolti nel magma confuso di una fusione in cui non c’è separazione e l’Altro non è distinto da noi quindi non ci può abbandonare nè rifiutare né tradire.
Il timore e il dolore della solitudine non sono altro che la nostalgia di quella fusione protettiva ma idealistica che abbiamo sperimentato nell’utero materno e nelle prime fasi della vita neonatale di cui non abbiamo coscienza ma di cui ci è rimasta traccia indelebile nell’inconscio, nello spirito e nell’anima.
Questa nostalgia spesso ci porta a ricercare quell’impossibile e fatale riunione che è tanto mortifera così come lo è per il feto rimanere nell’utero materno oltre i nove mesi.
Chi teme la solitudine prova in realtà, in maniera estrema e coercitiva, la nostalgia di tale stato perché non ha sperimentato nell’infanzia la sicurezza di base e fiducia nell’altro che poi diviene fondamentale nello strutturare la fiducia di Sé, quell’”Io sono” che si declina non appena il bambino comprende che la mamma non sparisce anche se va nell’altra stanza, che poi torna, torna sempre.
Quando il bambino esperisce questa condizione attraverso i gesti e la comunicazione non verbale della madre, o di chi si prende cura di lui e quindi esperisce se stesso come riconosciuto in quanto entità individuale e a sestante, riesce ad imparare a “stare da solo” nel senso winnicottiano del termine, ossia a comprendere che può allontanarsi dalla madre, (sua base sicura e fonte di sopravvivenza fisica ed emotiva), esplorare il mondo, uscire dalla diade protettiva, per poi farvi ritorno ogni volta che ne ha necessità e desiderio, perché la madre sarà sempre lì ad attenderlo.
In questi termini intendiamo sia la madre esterna (ovvero la figura di riferimento che si prende cura del bambino) ed in seguito la madre interiorizzata fonte interna di sicurezza e fiducia.
Mancando tale esperienza, il bambino vive il terrore di essere abbandonato, cosa che nel linguaggio inconscio ed emotivo equivale all’annientamento, all’annichilimento, alla minaccia della non sopravvivenza, del non-senso, della non-vita.
Figure materne assenti emotivamente o fisicamente il più delle volte per insicurezza, senso di inadeguatezza, paura oppure perché neppure loro hanno fatto l’esaltante e vitale esperienza di affidamento e fiducia, non sostenute da un contesto familiare e affettivo solido, possono, mai intenzionalmente, quasi mai consapevolmente produrre queste ferite che una volta cristallizzate saranno l’imprinting per le successive relazioni ed interazioni con il mondo producendo meccanismi disfunzionali declinabili nelle più varie forme nevrotiche alla cui origine c’è sempre il bisogno ASSOLUTO dell’Altro perché l’Altro implica la propria Sopravvivenza.
Anche il comportamento del padre ha un suo ruolo in questa formazione disfunzionale, poiché egli è il primo rappresentate della presenza dell’Altro in quanto tale. E’ il padre che rompe la diade madre-bambino e mostra a quest’ultimo che fuori c’è dell’altro da vedere e vivere…che fuori da quel guscio lo aspetta un mondo bello e avventuroso. I bambini che non sono curiosi o quelli troppo timorosi hanno sperimentato un assenza di Altro o peggio ancora hanno sperimentato la presenza di un Altro negativo, minaccioso, presenza altresì spesso corroborata da una difficoltà della madre a separarsi dal bambino instillando così in lui la percezione del pericolo e della minaccia.
Data tale premessa, ossia, se questa ferita che potremmo definire Narcisistica in senso sia assoluto che figurato perché colpisce direttamente l’Io nella sua nascita e strutturazione, si struttura nelle prime fasi della vita e senza che ve ne sia coscienza (anche spesso negli adulti che si occupano del bambino) e che poi determina come una traccia in nuce il nostro stare nel mondo, come si può in età successiva ristabilire l’ordine, rimettere le cose apposto, curare la ferita? Ossia comprendere, nel nostro essere più profondo, che se anche sono solo non muoio, sopravvivo, perché ho tutte le risorse e gli strumenti per stare bene? E che in fondo solo non lo sono mai perché sono sempre in compagnia di me stesso? L’unica possibile perché anche quando sono con gli altri sono solo ossia separato dall’Altro in quanto Alterità cioè un Tu separato da un Io?
Recriminare e incolpare qualcun altro non è la soluzione più efficace e neppure lo è compiangersi ed autocommiserarsi per l’ingiustizia subita.
La soluzione dal mio punto di vista è riprendere da dove il meccanismo si è inceppato, da dove quel qualcosa è andato storto e ci ha fatto sentire passabili di minaccia per la nostra sopravvivenza, da dove abbiamo avuto tanta paura da rimanerne immobilizzati. Ritrovare dentro di noi quel bambino spaurito, prenderlo per mano e presentargli quel ragazzo, quella ragazza, quell’adulto che siamo diventati e fare in modo che i due facciano amicizia, che si conoscano, che si ri-conoscano, che si consolino a vicenda, che si sostengano e camminino insieme nell’affrontare tutti i compiti che la vita metterà loro davanti.
Sì, andare avanti, non continuare a camminare con lo sguardo rivolto all’indietro, perché altrimenti è inevitabile che si inciampi…..imparando che siamo esseri imperfetti e incompleti, che possiamo cadere ma sappiamo anche rialzarci, da soli, perché ne abbiamo le capacità e le risorse e l’Altro (l’amico/a, la/il fidanzata/o, il marito, la moglie, la madre, il padre, il fratello, la sorella ecc…) non potrà mai sostituirci nell’affrontare tali compiti. Potrà aiutarci solo se sappiamo aiutarci da soli, potrà sostenerci solo se siamo noi i primi a farlo, potrà consolarci solo se noi ci consoliamo, potrà amarci solo se noi già ci amiamo. Poiché in questo modo, cioè se noi amiamo noi stessi per quello che siamo, anche l’Altro potrà amarci per quello che siamo e sentirsi amato per quello che è, non come un oggetto intercambiabile utile solo a colmare un nostro vuoto e quindi non ri-conosciuto nella sua individualità, nel suo essere Altro da noi.
Fare amicizia con sé stessi ed amarsi significa accettarsi, con le proprie debolezze e le proprie paure, le idiosincrasie e i difetti ma anche con i pregi, le doti, le qualità, la forza, il coraggio, imparando ad essere indulgenti con se stessi, e che se anche il mondo ci frana addosso, se cadiamo, soffriamo, siamo rifiutati o derisi, abbiamo dentro di noi le risorse per riaffermarci, tornare a sorridere, rialzarci, ricostruire il nostro mondo.
Ciononostante a volte è più comodo non ricostruire nulla e andare alla deriva. Perché per ricostruire, rialzarsi, tornare a sorridere e riaffermarsi serve impegno, responsabilità e fatica e quindi meglio delegare, meglio dirsi che non siamo capaci, che abbiamo bisogno di qualcuno. Ma in realtà abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi dentro di noi, la nostra forza, il nostro coraggio.
Solo in questo modo l’incontro con l’altro potrà essere creativo, produttivo, autentico ed armonioso: l’incontro di un Io e di un Tu.
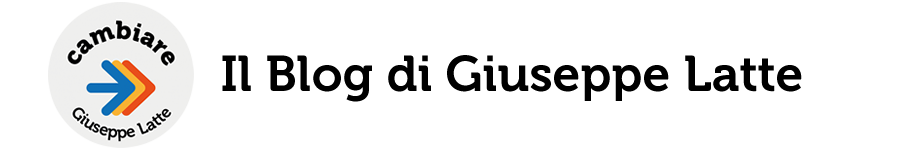
Commenti recenti